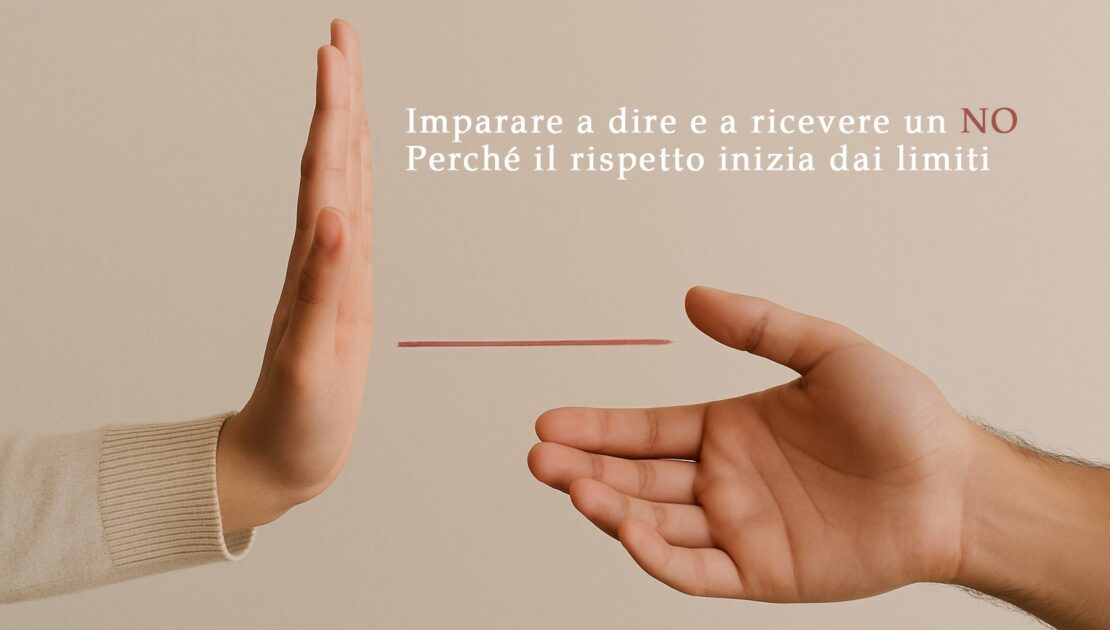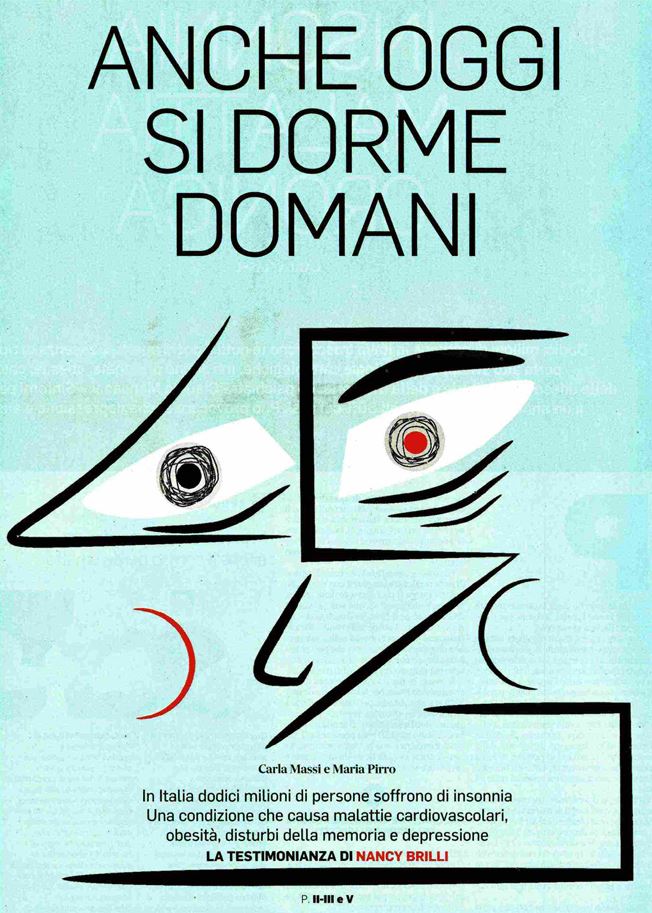Sono le parole del Professor Claudio Mencacci, Presidente della SINPF, intervistato oggi da Agostino Gramigna per il Corriere della Sera, a margine dell’ultimo femminicidio che ha scosso l’opinione pubblica.
Nel suo intervento, Mencacci sottolinea quanto sia urgente educare i giovani alla gestione delle emozioni, del rifiuto, della frustrazione — temi che troppo spesso restano esclusi dal contesto familiare e sociale.
«𝐿𝑎 𝑡𝑜𝑠𝑠𝑖𝑐𝑖𝑡𝑎̀ 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑎 𝑚𝑎𝑠𝑐𝑜𝑙𝑖𝑛𝑖𝑡𝑎̀ ℎ𝑎 𝑎𝑛𝑐𝑜𝑟𝑎 𝑓𝑟𝑢𝑡𝑡𝑖 𝑣𝑒𝑙𝑒𝑛𝑜𝑠𝑖. 𝐼𝑙 𝑝𝑖𝑢̀ 𝑔𝑟𝑎𝑣𝑒 𝑒̀ 𝑞𝑢𝑒𝑙𝑙𝑜 𝑐ℎ𝑒 𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑐ℎ𝑒 𝑙𝑎 𝑔𝑒𝑙𝑜𝑠𝑖𝑎 𝑒̀ 𝑢𝑛 𝑔𝑒𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑖 𝑎𝑚𝑜𝑟𝑒.»
Alla base della violenza c’è spesso la paura di non valere abbastanza, di non essere amati se non si possiede l’altro. Un nodo che si intreccia con una cultura patriarcale e con l’iperprotezione educativa:
«𝐴𝑏𝑏𝑖𝑎𝑚𝑜 𝑐𝑟𝑒𝑠𝑐𝑖𝑢𝑡𝑜 𝑢𝑛𝑎 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑐ℎ𝑒 𝑓𝑎 𝑓𝑎𝑡𝑖𝑐𝑎 𝑎 𝑡𝑜𝑙𝑙𝑒𝑟𝑎𝑟𝑒 𝑙𝑎 𝑡𝑟𝑖𝑠𝑡𝑒𝑧𝑧𝑎 𝑒 𝑙𝑎 𝑠𝑒𝑝𝑎𝑟𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒. 𝐼 𝑔𝑖𝑜𝑣𝑎𝑛𝑖 𝑠𝑜𝑛𝑜 𝑚𝑒𝑛𝑜 𝑒𝑠𝑝𝑜𝑠𝑡𝑖 𝑎𝑙 “𝑛𝑜”, 𝑠𝑝𝑒𝑠𝑠𝑜 𝑠𝑒𝑛𝑧𝑎 𝑠𝑡𝑟𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡𝑖 𝑝𝑒𝑟 𝑎𝑓𝑓𝑟𝑜𝑛𝑡𝑎𝑟𝑒 𝑖𝑙 𝑑𝑜𝑙𝑜𝑟𝑒.»
Come SINPF riteniamo fondamentale promuovere un cambiamento culturale e clinico: educare fin dall’infanzia all’empatia, al rispetto, ai confini; sostenere le famiglie nel difficile compito di guidare i figli, anche attraverso i “no”; integrare nella società una cultura della salute mentale basata sulla relazione, non sul controllo
Ogni “no” accolto e compreso è un passo verso la prevenzione.
Ogni parola giusta, detta al momento giusto, può fare la differenza.
🔗 Per approfondire il ruolo della salute mentale nella prevenzione della violenza, segui i canali ufficiali della SINPF.
📞 Se tu o qualcuno che conosci ha bisogno di aiuto:
1522 – Numero gratuito e attivo h24 contro la violenza e lo stalking
…
Intervista Corriere della Sera.
«La tossicità della mascolinità ha ancora frutti velenosi. Il più grave è quello che dice che la gelosia è un gesto di amore». Claudio Mencacci, Presidente SINPF – psichiatra e saggista, parla dell’ultimo femminicidio.
Maschi, spesso giovani, che non accettano il rifiuto femminile. E uccidono. Ci vede le tracce del maschilismo patriarcale?
«C’è un modello culturale che è duro a morire. Che confonde la passione con il possesso. Ma c’è anche altro: “Se lei se ne va io non valgo nulla”. Così pensano. Hanno il terrore di non essere abbastanza».
Carenze emotive che si aggiungono al contesto ereditario del patriarcato?
«Abbiamo cresciuto una generazione che fa fatica a tollerare la tristezza e la separazione, che non sa cosa farsene del valore».
C’è una spiegazione?
«Occorre guardare al contesto culturale e familiare. I giovani sono meno esposti al “no”. Vedo carenza di educazione affettiva. In casa si parla pochissimo di come gestire le emozioni».
Però neanche 40 o 50 anni fa i genitori parlavano ai figli di queste cose.
«Certo, accadeva anche in passato. Ma per altre ragioni c’era una maggiore tolleranza alle fragilità, c’era una maggiore resilienza dovuta ai famosi “no” dei genitori. I loro figli erano addestrati a ricevere limiti».
Sta dicendo che i maschi di oggi andrebbero addestrati. E meglio.
«Sì. Perché sono meno inclini a gestire il dolore. I ragazzi “Z” e “Alpha”, nati dopo il 1997, sono educati da genitori iperprotettivi. E dispongono di pochi strumenti per elaborare il rifiuto in modo sano».